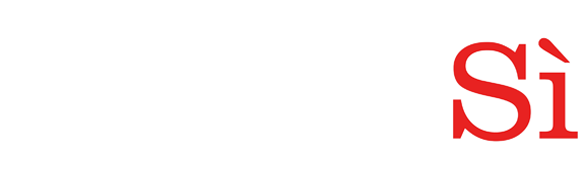Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha celebrato stamattina alle 10, nella Cattedrale “San Lorenzo”, la messa della Domenica delle Palme. Alla celebrazione, in ottemperanza alle disposizioni anti coronavirus, non hanno partecipato fedeli.
Ecco il testo della sua omelia
“Cristo trionfante”: così si esprime la liturgia iniziale della domenica delle palme; poi si passa all’ascolto della Parola di Dio con la proclamazione del Passio dal vangelo di san Matteo. Si passa dal “Cristo trionfante” al “Cristo crocifisso”: dal triumphans al patiens. La domenica di Passione ha questo duplice volto: l’ingresso trionfale a Gerusalemme e l’inizio della Passione. Oggi finisce la Quaresima, i quaranta giorni che ci hanno preparato alla settimana maggiore, e cominciano gli otto giorni in cui viviamo il mistero pasquale con la ricchezza dei riti della pietà popolare e i contenuti profondi della liturgia. Nel 2020 siamo costretti a celebrare la Pasqua in modo inedito, ma ugualmente reale.
Una palma per risorgere
Partiamo dalle palme. Questa domenica mi riporta a due gesti che ho visto fare dai miei genitori quando ero bambino: dopo la benedizione delle palme in chiesa ci si recava al cimitero a portare una palma ai parenti defunti; il giorno dopo, si andava in campagna a mettere la palma più lunga in un punto dove potesse rimanere visibile tutto l’anno. Era il segno della comunione con i defunti chiamati a risorgere: l’ingresso al cimitero lo ricordava con la scritta Resurrecturis, che significa “a coloro che risorgeranno”; la palma in campagna era segno di comunione con la terra che si accingeva a fiorire in primavera. In quel modo il nostro omaggio a “Cristo trionfante”, come lo definisce la liturgia di oggi, entrava nelle nostre esistenze, unendo a sé la nostra morte e il nostro lavoro. Il segno di croce davanti ai morti e sulla terra benedetta dalla palma ci lasciava la certezza che Cristo trionfante trascina nel suo trionfo i nostri defunti e il nostro lavoro quotidiano. Gesti simili ho visto anche in case private e in posti di lavoro: la palma viene abitualmente collocata vicino alle foto dei familiari defunti. È Gesù Risorto che dona la vita perché libera il ciclo naturale dalla ripetitività senza senso e orienta la storia verso la meta dei cieli nuovi e della terra nuova”.
“Con questi ricordi – ha proseguito monsignor Fragnelli – oggi voglio rivolgere il mio e vostro pensiero ai defunti di questo tempo inedito, che alcuni giudicano tempo di punizione e altri, illuminati dalla Parola di Dio, considerano tempo di grazia, deserto che invita alla conversione e a una nuova fioritura umana e cristiana. Vorrei portare idealmente la palma ad alcuni nostri fratelli che ci hanno lasciato nei giorni scorsi: a Davide di San Vito, alunno dell’Alberghiero, a Roberta, della parrocchia di san Paolo, e a Pasquale di Castellammare, l’anziano morto di Coronavirus da pochi giorni. Ai loro familiari vada un saluto affettuoso da tutta la comunità diocesana. La nostra palma va a tutti i defunti che in Italia e nel mondo ci hanno lasciato per Covid-19; idealmente va in tutti i luoghi di morte che affliggono la terra, nostra casa comune. Vorremmo poter annunciare a tutti il trionfo di Cristo su ogni forma di morte, di malattia e di egoismo. La palma possa essere quel segno biblico che annunciò la vita dopo il diluvio universale, un piccolo segno di pace e di vita che il Padre ci dà per superare il silenzio triste ed enigmatico di queste settimane. Mi piace pensare che quel segno lo riceviamo oggi da tutti coloro che si stanno dedicando con grande generosità ai malati in ogni parte del pianeta. Siamo certi che con Gesù questa palma è e sarà segno di vittoria, di vita rinnovata nella creatività dell’amore. Come ci ha detto papa Francesco venerdì scorso in televisione”.
Il rosso dell’alleanza
Il colore rosso della liturgia parla al nostro cuore. Ha una drammatica attualità. Il racconto della Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo san Matteo mette al centro il calice del sangue: è il filo conduttore della sua storia e della storia di ogni uomo. Durante l’ultima cena, dopo la benedizione del pane, Gesù “prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati” (Mt 26,27-28). Ma qual è il significato profondo di questo sangue, che tutti siamo chiamati a bere? La morte di Gesù in croce porta a termine l’alleanza sancita sul monte Sinai con il sangue di alcuni animali (Es 24,4-8); in più il sangue di Gesù porta a pienezza l’alleanza nuova predetta da Geremia (Ger, 31,31-34). Il suo sangue ha valore universale: il suo sacrificio è salvezza per la moltitudine dell’umanità di ieri, di oggi e di sempre. Nel rosso del suo sangue vengono cancellati tutti i peccati degli uomini: questo è un elemento specifico del racconto di san Matteo. Chi legge attentamente questo vangelo scopre che Matteo soltanto associa il versamento del sangue alla remissione dei peccati. Le parole di Gesù sul calice evocano i peccati di Israele: si uccide non solo con l’omicidio, ma anche l’adirarsi col fratello. Il peccato ha una dimensione comunitaria e sociale: nel rapporto con l’avversario e con i familiari. La logica è la stessa in tutto il vangelo: non basta non odiare, bisogna amare il nemico. È questa la risposta di misericordia verso i cattivi ai quali Dio non toglie la luce del sole. Ma come avverrà la liberazione dai peccati? Matteo lo racconta nell’istituzione dell’eucaristia: avrà luogo non con gesti o parole, qualcosa di ‘estrinseco’ a Gesù, ma col dono della vita stessa del Messia. “La morte di Gesù è per il bene dei peccatori e, in Matteo, ha un significato chiaramente espiatorio” . Il Cristo trionfante è colui che dona se stesso in espiazione dei peccati dell’umanità. Giuda lo riconosce quando ammette di aver tradito il “sangue innocente” (Mt 27,4). Nel calice di Gesù è presente il rosso-sangue degli innocenti di tutti i tempi, dai bimbi uccisi nel grembo materno alle vittime della guerra; dalle donne oggetto di violenza e di femminicidio ai minori e alle persone vulnerabili calpestati, per arrivare agli sfruttati di ogni tipo.
Lavarsi le mani?
In questo tempo è insistito un monito per contenere la diffusione del virus: lavarsi spesso le mani. Il Vangelo ci ha presentato Pilato che si lava le mani, dichiarandosi innocente del sangue di Gesù. Questa immagine ci ricorda che per costruire il futuro, dopo questa terribile ora, nessuno può lavarsi le mani, scaricando sugli altri le proprie responsabilità. In queste settimane sono venute allo scoperto tre cose principali: il numero delle epidemie potrà crescere, perché “i nostri modelli di sviluppo non tengono in considerazione l’equilibrio degli ecosistemi né il rispetto per la casa comune”; secondo: il mondo globalizzato esige che la conversione dei nostri stili di vita. “Costruiamo società mosse dal dogma del profitto e dell’utilitarismo, che operano come mercati massificati che non dormono mai, e praticano un drammatico disinvestimento sull’umano”. L’essere umano è ridotto a bene di consumo da produrre e scartare a seconda degli interessi prevalenti. Terzo: non è sufficiente agire per la paura di non morire. Dobbiamo rilanciare la nostra alleanza con la vita. C’è una verità nella bellezza del cuore dell’uomo, e in quella del cuore del mondo, che noi siamo chiamati a riconoscere e ospitare. Lavarsi le mani per prevenire il virus, non lavarsele di fronte al compito di costruire il mondo futuro nella solidarietà responsabile e nella fede adulta”, ha concluso il vescovo augurando buona settimana santa a tutti.